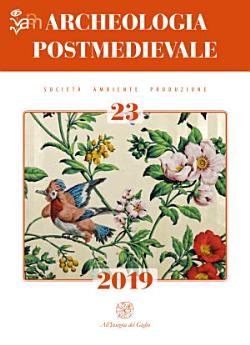APM – Archeologia Postmedievale, 23, 2019
Über dieses E-Book
Il contributo di Giuliano Volpe si presenta originale e innovativo soprattutto per la metodologia, per una riflessione sulle inattese potenzialità anche qualitative del patrimonio e sul tema della delicatezza dell’intervento strutturale nel recupero dell’edilizia storica, che per le informazioni in sé, utili e importanti comunque per lo studio delle trasformazioni di un campione del centro storico medievale di Foggia, a seguito del terremoto che colpì questo centro nel XVIII secolo.
Il gruppo di ricerca di Archeologia Medievale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia discute il contributo dei dati archeomalacologici per l’interpretazione dei processi formativi della stratificazione archeologica e della sua interpretazione. Il caso di studio, ubicato nel centro storico di Marano (Cupra Marittima) appare significativo, in quanto sottolinea il ruolo dello studio (qualitativo e quantitativo) della malacofauna per individuare le pause dei processi di crescita della stratificazione e la formazione di paesaggi ruderali, talvolta estesi, talvolta limitati invece a singoli ambienti.
Chiara Maria Lebole e di Roberto Sconfienza presentano un importante approfondimento sul tema dell’architettura militare del Ducato di Savoia nel XVII secolo, in quanto gli Autori illustrano i risultati delle ricerche su Le difese campali fra La Thuile e il Piccolo San Bernardo alla fine del XVII secolo, condotte come in altre occasioni con un’intensa interazione tra fonti scritte e fonti archeologiche.
Il saggio di Luciano Mingotto sul restauro e sulle indagini stratigrafiche condotte durante il restauro della seicentesca villa Morlini-Trento a Costozza di Longare (Vicenza), a partire da questo case study suggerisce anche una riflessione più generale sul tema della tutela e della documentazione delle tracce delle trasformazioni nel tempo del patrimonio architettonico rappresentato dalle grandi ville aristocratiche d’età moderna e della fragilità dei resti delle azioni costruttive, funzionali o decorative.